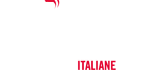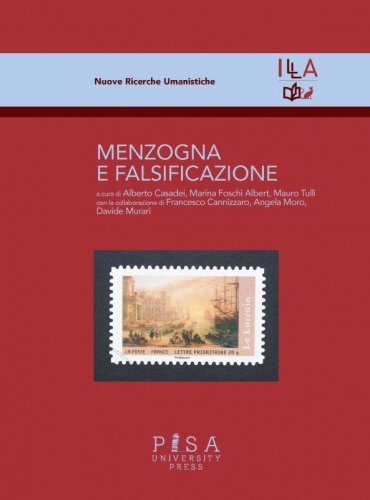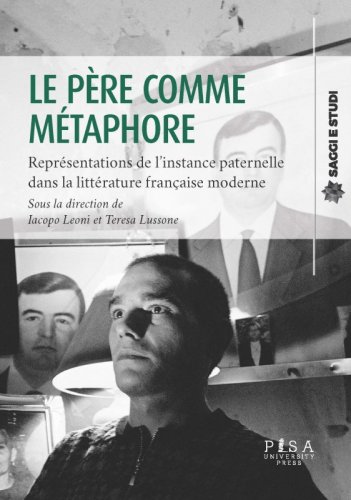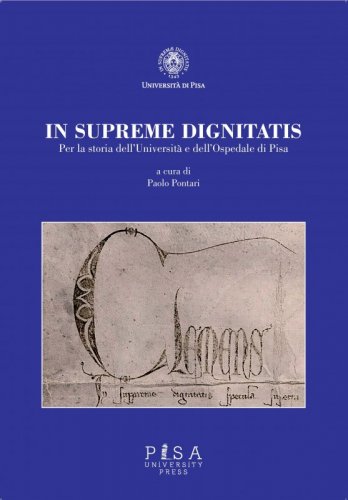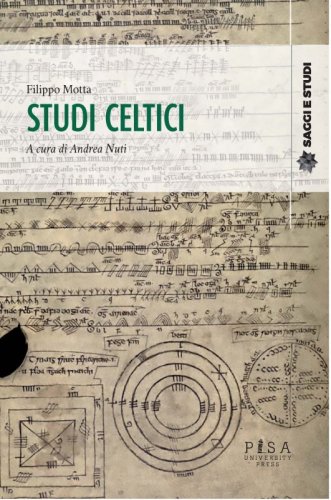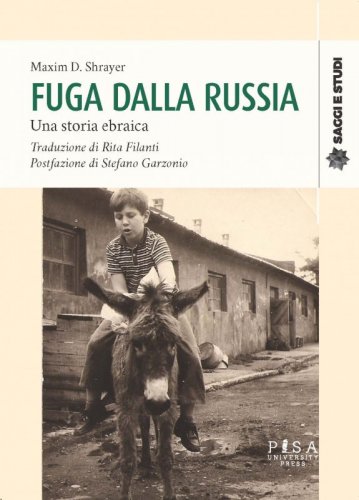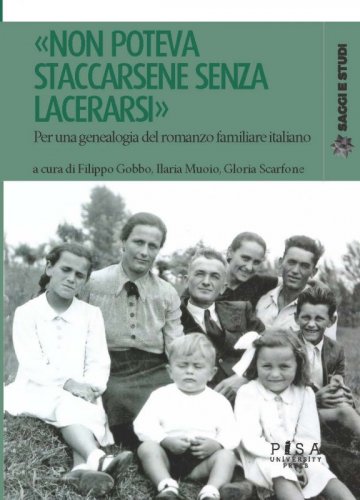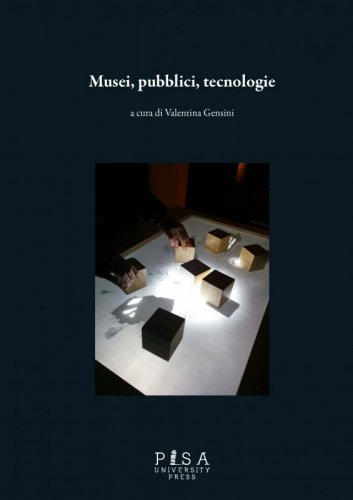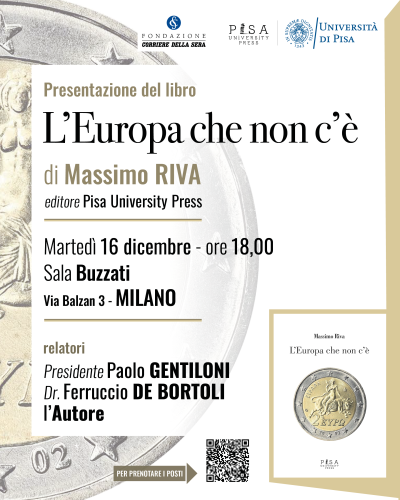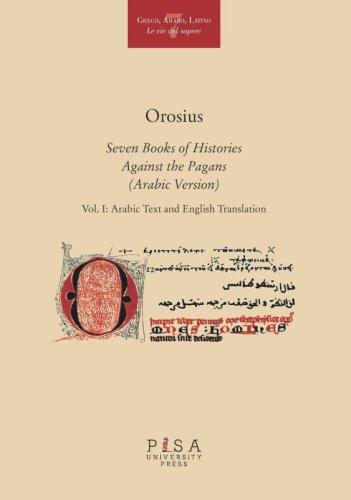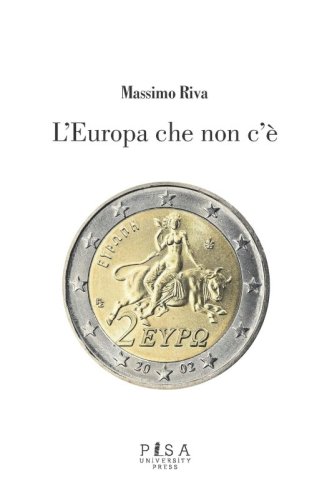Scienze dell’antichità, filologico letterarie e storico artistiche
Egitto e Vicino Oriente 2020
vol. XLIII 2020
Autori vari
editore: Pisa University Press
pagine: 160
In questo numero: Marilina Betrò, La leonessa di Medinet Madi. Ricordando Edda Bresciani (1930-2020).Stefan Bojowald, Etymologische Kleinigkeiten VII: das ägyptische Wort „bhn“ „Mantel“/ Etymological BitsVII:the Egyptian word “bhn“ “coat“.Stefan Bojowald, Eine kleine Bemerkung zur angeblichen Bedeutung „Milchkrug“ des ägyptischen Wortes „nHfk“.Gianluca Miniaci, ‘Shabti precursors?’ An unusual group of human figures from Harageh tomb 112 (late MiddleKingdom, c. 1800 BC).Camilla Saler, I Depositi in giara b e c del tempio di Ba’alat Gebal a Biblo.De Marco, La statuaria lignea nell’antico Egitto: considerazioni a partire da una statua inedita.Marilina Betrò, Paolo Del Vesco, Mattia Mancini, Emanuele Taccola, Two new tombs in the forecourt ofM.I.D.A.N.05 at Dra Abu el-Naga. Preliminary report of the 2018 season.Julie Santoro, I titoli di Soprintendente ai cavalli e di Capo di scuderia come espressione di una ‘nobiltàequestre’ durante l’Età Ramesside.Flora Silvano, Amuleti funerari dalla tomba di Bakenrenef (L.24) a Saqqara.Michele Degli Esposti, Philipp Ramorino, A note on some Iron Age inscribed sherds from the ancient Oasis of Salut.
Dante e la Toscana occidentale
Atti del convegno di Studi (Lucca-Sarzana 5-6 ottobre 2020)
editore: Pisa University Press
pagine: 644
Il Progetto di ricerca dell’Ateneo di Pisa Testi, testimonianze e documenti danteschi in area toscana tra il XIV e il XVI secolo, realizzatosi tra il 2018 e il 2020, ha consentito di svolgere nuove e sistematiche ricerche in numerosi archivi, e in particolare in quelli di Lucca e della Lunigiana. Oggetto di indagine sono state le testimonianze del periodo in cui Dante soggiornò sicuramente in queste zone, tra il 1306 e il 1308, ma anche altre relative alla cultura e all’arte locale del XIII e XIV secolo. Gli Atti che qui si pubblicano propongono i testi delle relazioni presentate al Convegno tenutosi a Lucca e a Sarzana rispettivamente il 5 e il 6 ottobre 2020. Il tema dell’esilio del poeta in Lunigiana e a Lucca è stato declinato sotto il profilo storico-documentario, letterario, linguistico e artistico, con particolare attenzione anche alla ricezione dei testi danteschi sino al Cinquecento (Daniello e Vellutello) e con un affondo sul dantismo di Augusto Mancini.
Con la collaborazione di Matteo Cambi.
Menzogna e falsificazione
editore: Pisa University Press
pagine: 344
Il volume prende avvio dal seminario Menzogna e falsificazione svoltosi nei giorni 17-19 ottobre 2019 presso il convento di San Cerbone. Il seminario ha avuto per tema gli statuti di verità dell’atto linguistico e letterario e il problematico rapporto che essi instaurano con lo spazio della finzione nel momento in cui l’atto si fa forma. Il dibattito si è mosso in particolare sulle possibilità di indagare, a partire dallo scarto tra finzione e falso e attraverso i differenti gradi della menzogna, le potenzialità del linguaggio e delle discipline che a vario titolo su di esso si fondano, conducendo a riflessione sui limiti imposti dalle singole prospettive disciplinari e sulle loro relazioni con altri saperi.
Con la collaborazione di Francesco Cannizzaro, Angela Moro e Davide Murari
Le père comme métaphore
Représentations de l’instance paternelle dans la littérature française moderne
editore: Pisa University Press
pagine: 144
À partir du XVIIIe siècle, on assiste à une mutation radicale de la figure paternelle dans le discours culturel, social et politique européen. L’imaginaire romanesque ne pouvait que refléter – dans les formes toujours obliques du langage artistique, mais pleinement reconductibles à une relation de cohérence schématique avec la réalité – les modifications historico-sociales dont le père a été l’objet. Qu’elle soit évanescente ou tyrannique, tendre ou violente, la paternité, telle qu’elle se fait jour dans la littérature, devient en effet le lieu d’un questionnement qui va bien au-delà de sa propre signification spécifique et revêt une portée métaphorique plus universelle. Portant sur des auteurs particulièrement significatifs de l’histoire littéraire française moderne, les contributions réunies ici se penchent sur cette question, avec une attention particulière portée au passage du paradigme aristocratique au paradigme bourgeois qui s’impose avec la Révolution. Mais les représentations de la paternité constituent en même temps un élément fondamental pour interroger les inquiétudes qui caractérisent la culture démocratique des XXe et XXI e siècles.
In supreme dignitatis
Per la storia dell'Università e dell'Ospedale di Pisa
editore: Pisa University Press
pagine: 176
Questo volume, che approda alla stampa per volontà del Rettore e con il patrocinio del Rotary Club Pisa Galilei, offre la prima edizione critica e diplomatica completa, con traduzione e commento, del più importante documento storico dell’Università di Pisa, la bolla In supreme dignitatis di papa Clemente VI per l’istituzione dello Studium generale (3 settembre 1343), e l’edizione commentata di uno sconosciuto e inedito fascicolo pergamenaceo con atti notarili quattro-cinquecenteschi riguardanti l’Ospedale di Pisa, recuperato di recente sul mercato antiquario e donato all’Università di Pisa. Le ragioni che legano queste e altre testimonianze indagate nel volume emergono dai saggi introduttivi a firma di P. Pontari, G. Albanese e M. Riccucci, che gettano luce su momenti salienti della storia universitaria, ospedaliera e artistica pisana tra Medioevo e Rinascimento, implicando personaggi e vicende di primo piano, come Lorenzo il Magnifico e il suo noto interesse per Pisa, per la sua Università, il suo Ospedale e le proprietà fondiarie del suo contado.
Studi Celtici
di Flippo Motta
editore: Pisa University Press
pagine: 520
Questo libro, nato con l’intenzione di onorare Filippo Motta in occasione del suo settantesimo compleanno, raccoglie ventidue dei suoi scritti tra quelli più rappresentativi dell’argomento prediletto in un’ampia attività scientifica di quasi mezzo secolo: la storia delle lingue celtiche. La selezione segue un filo cronologico nella produzione dell’Autore che è in grado di dare conto anche dell’evoluzione di molte delle principali tematiche di linguistica celtica nel corso degli ultimi cinquant’anni. Al tempo stesso la scelta dei lavori inclusi nel volume offre un’organizzazione interna e un raggruppamento per ampi settori in grado di fornire un panorama a tutto campo delle antiche lingue celtiche: il celtiberico, il britannico e l’antico irlandese, con particolare riferimento alla fase arcaica dell’ogam, il gallico, il leponzio e il celtico d’Italia. Vi sono poi scritti di questioni etimologiche e lessicali, studi a carattere antropologico e culturale, saggi di storia della celtistica.
Completa il volume una bibliografia dell’autore.
Itinerari del Riccio Rapito
Satira e nuova scienza nell'Italia dei Lumi
di Francesca Fedi
editore: Pisa University Press
pagine: 190
La straordinaria fortuna del Rape of the Lock di Alexander Pope si spiega solo alla luce della plasticità di questo piccolo capolavoro eroicomico, capace di trasformarsi e di adattarsi a prospettive satiriche diverse man mano che la crisi della società di Ancien Régime portava in primo piano nuovi obiettivi polemici. Seguire gli itinerari delle due prime traduzioni italiane (di Antonio Conti e Andrea Bonducci) ha permesso di comprendere quando e in che modo il Riccio sia stato riletto e reinterpretato, in corrispondenza di alcuni snodi del dibattito culturale europeo: le polemiche suscitate dalla rivoluzione newtoniana, gli sviluppi del libertinismo filosofico, le spinte giurisdizionaliste, la diffusione della massoneria. Le traduzioni del Riccio, inoltre, circolarono legandosi alle vicende editoriali di altri testi, molti dei quali sottoposti a censura (da Le Comte de Gabalis alle opere di Swift, dalle Lodi di Newton di Thompson alla Chiave del Gabinetto di Borri e alla Lettera apologetica di Raimondo di Sangro), finendo a loro volta per orientarne la ricezione. Francesca Fedi insegna Letteratura Italiana all’Università di Pisa. I suoi interessi di ricerca sono rivolti alle forme dell’argomentare per paradossi nel primo Cinquecento, alla letteratura dell’età illuministica, all’estetica del Neoclassicismo, ai rapporti tra cultura massonica e generi letterari. Ha pubblicato in volume e in rivista studi, tra l’altro, su Machiavelli, Parini, Alfieri, Foscolo, Leopardi. È attualmente coordinatrice di un PRIN dal titolo La costruzione delle reti europee nel ‘lungo’ Settecento: figure della diplomazia e comunicazione letteraria.
Prima di Platone
Plotino e gli inizi della filosofia greca
di Giulia Guidara
editore: Pisa University Press
pagine: 242
Anassagora, Democrito e gli atomisti, Empedocle, Eraclito, Parmenide, Pitagora e gli antichi pitagorici vengono richiamati piú volte all’interno delle Enneadi. Ma per quali ragioni Plotino vi ricorre? E con quali obiettivi? Il presente volume tenta di rispondere ai due interrogativi, passando in rassegna tutti i riferimenti ai preplatonici delle Enneadi. Il nucleo dello studio è un’analisi dei passi in cui Plotino si serve dei preplatonici per argomentare le proprie teorie, o per dimostrare il loro sostanziale accordo con i migliori insegnamenti della tradizione filosofica greca. Tale analisi è condotta con un approccio teoretico e storico al tempo stesso: l’attenzione è rivolta sia alla funzione che ogni riferimento svolge all’interno della trattazione, sia alle sue possibili fonti. L’obiettivo è quello di ricostruire, in tutte le sue sfaccettature, le idee di Plotino sulla fase nascente del pensiero greco, e il contesto in cui tali idee si sono formate. I riferimenti ai preplatonici che non danno alcuna informazione al riguardo (perché sono dubbi, o perché non hanno un vero e proprio ruolo nelle argomentazioni) sono riportati nelle appendici. In questo modo, il volume si propone di fornire al lettore un quadro completo del modo in cui Plotino plasma il pensiero preplatonico e lo integra nella sua filosofia.
Fuga dalla Russia
Una storia ebraica
di Maxim D. Shrayer
editore: Pisa University Press
pagine: 420
Nel suo primo libro di memorie, Aspettando America, pubblicato in Italia proprio dalla Pisa University Press nel 2017, Maxim D. Shrayer aveva narrato della sua permanenza in Italia nell’anno 1987 in attesa del visto statunitense dopo essere emigrato con la famiglia dall’Unione Sovietica. Ora, in questo secondo contributo, Fuga dalla Russia, l’autore fornisce un’intensa e viva ricostruzione della sua vita precedente all’emigrazione con uno sguardo attento al destino dei cittadini di origine ebraica costretti a lasciare la Russia. Se ne ottiene un quadro variegato e genuino della società sovietica negli ultimi anni del potere comunista e, allo stesso tempo, un sincero tributo dell’autore alla sua “prima” patria, a un mondo che viene rivisitato con la precisione analitica dello storico della cultura e la sensibilità e la verve affabulatoria dello scrittore.Traduzione ri Rita FilantiPostfazione di Stefano Garzonio
«Non poteva staccarsene senza lacerarsi»
Per una genealogia del romanzo familiare italiano
editore: Pisa University Press
pagine: 300
Che cos’è il romanzo familiare? È possibile considerarlo una categoria critica che ci aiuti a leggere alcune opere pubblicate a partire dalla seconda metà dell’Ottocento? Concentrandosi sul panorama italiano,
«Non poteva staccarsene senza lacerarsi» prova a rispondere a queste domande, ripercorrendo alcune tappe centrali della fortuna del genere.
Figura tra le più rilevanti del nostro immaginario sociale, la famiglia viene qui osservata attraverso le sue rappresentazioni letterarie: protagonista collettivo del racconto, lo struttura nella forma e ne determina i temi. La prospettiva genealogica del volume offre così la possibilità di ricostruire una fase poco nota della storia del novel e di guardare alla trasformazione dell’idea di famiglia in un’ottica inedita.
Musei, pubblici, tecnologie
editore: Pisa University Press
pagine: 172
Il tema della centralità del pubblico e del suo coinvolgimento nella fruizione e interpretazione del museo ha finalmente coinvolto generazioni di studiosi a rileggere questo dispositivo anche alla luce di nuove sensibilità cognitive; per contro il focus su Audience Development e Public Engagement ha indirizzato il confronto in modo esclusivo, tanto da rappresentare un mantra a cui hanno atteso i più vivaci tecnici ed esperti, talvolta spintisi a considerare il pubblico come consumatore.
Nel trinomio Musei Pubblici Tecnologie il tema che emerge con grande forza e attualità è quello dell’Accessibilità: accesso al Patrimonio, da preservare e valorizzare in una logica inclusiva, che lo renda fruibile fisicamente, intellettivamente e socialmente; accoglienza nel segno di una cultura che rivendichi il diritto di chiunque a godere l’arte e i suoi significati profondi; coinvolgimento del pubblico al fine di stimolare i visitatori come protagonisti di un’esperienza estetica vibrante nonché straordinaria occasione di formazione ad una cittadinanza consapevole. In prima linea accanto al pubblico ci sono curatori, storici dell’arte, addetti alla comunicazione e alla mediazione, architetti e designer, ma anche gli artisti, capaci di una singolare abilità nella mediazione del Patrimonio.
Nove faraoni
di Edda Bresciani
editore: Pisa University Press
Un seducente viaggio nella regalità dell’antico Egitto, da Cheope ad Alessandro Magno.
Come si generano dal vivo di una tradizione millenaria la mutazione storica e l’incontro tra civiltà.
Roberto Longhi nel vivo dell'arte del '900
di Mauro Pratesi
editore: Pisa University Press
pagine: 180
Ho sempre inteso Longhi, fin dai primi approcci, come una sorta di Pinocchio geniale della storia dell’Arte mondiale, creatore, finanche, dispettoso, con un estro e un intuito ineguagliabile a tutt’oggi. Tra le tante immagini iconografiche più note di Longhi ho scelto quella dimessa, mentre gioca a bocce con i cari amici Messina e Carrà, con in testa quel cappellino di carta che tanto può assomigliare a quello di “mollica di pane” che Geppetto aveva fatto al suo Pinocchio, e, inoltre, lo sguardo socchiuso e quella smorfia arguta sorniona che rivela tutto il senso acuto e beffardo di Longhi. Quando studiavo sui testi “longhiani”, a volte, quei testi mi facevano fantasticare e immaginare l’autore sulle note di una famosa canzone: Bamboleo cantata divinamente da Josè Feliciano. A cinquant’anni dalla morte del grande maestro degli studi di storia dell’arte ho ritenuto doveroso rendergli omaggio, umilmente, rimettendo insieme i miei testi di argomento strettamente “Longhiano”. In fondo, la scoperta di Longhi, per me è stata analoga, con le dovute proporzioni del caso e della storia, a quella che fu per Pier Paolo Pasolini, laddove il grande intellettuale aveva scoperto in Longhi “la rivoluzione” nel “suo lessico” e “la completa novità” nell’”ironia” che “ non aveva precedenti” insieme alla “sua curiosità” che “non aveva modelli”.
Lecture Notes on Irony and Satire
di Marcella Bertuccelli Papi, Alessandro Aru
editore: Pisa University Press
pagine: 170
This volume brings together two studies which are meant to highlight the complexities of irony as a form of communication. Both studies offer an overview of the major contemporary theoretical approaches to irony. Bertuccelli’s paper further focuses on the relationship between irony and satire, arguing that the two notions should not be conflated even though they exhibit areas of overlapping, among which the crucial property of expressing a set of attitudes revolving around the notion of “criticism”. Aru’s paper explores the uses of irony in a corpus of over 600 tweets of socio-political communication, showing how ironic English and Italian expressions do not seem to differ essentially in their forms and functions.