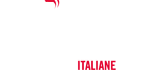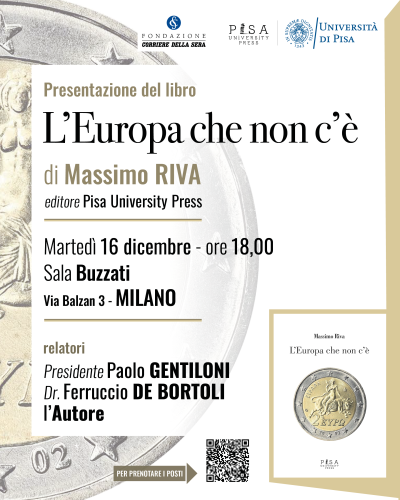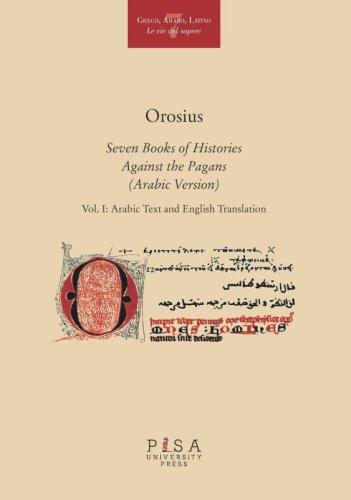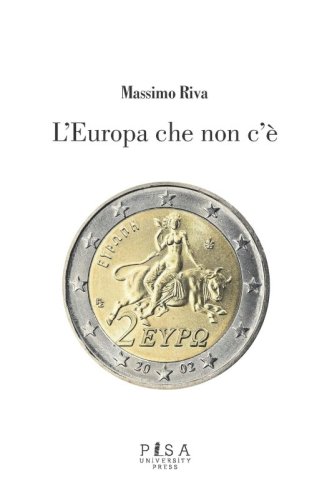Scienze dell’antichità, filologico letterarie e storico artistiche
Statue vestite. Prospettive di ricerca
editore: Pisa University Press
pagine: 276
Il volume – esito di un incontro tra studiosi di diversa specializzazione e nazionalità, a conclusione di un progetto di ricerca promosso dall'Università di Pisa – offre una molteplicità di punti di vista sulla realtà del vestire le statue: dall'identità artistica dei manufatti ai loro aspetti devozionali, dalla riflessione antropologica ai modi della loro musealizzazione. Ad uno sguardo privilegiato sulla Toscana nord-occidentale si aggiunge – oltre alla presenza di interventi di più generale contestualizzazione – quello su due aree particolarmente significative per questo fenomeno culturale, quali la Spagna e la Basilicata. I singoli saggi si devono a Elisa Acanfora, Paola Antonella Andreuccetti, Manuel Arias Martinez, Clara Baracchini, Francesca Barsotti, Isabella Botti, Antonella Capitanio, Marco Collareta, Fabio Dei, Gabriele Donati, Francesca Fabiani,Daria Gastone, Valeria E.Genovese, Antonella Gioli, Sonia Lazzari, Paola Martini,Francesca Pisani, Michele Rak, Paola Refice, Cinzia Maria Sicca, Barbara Sisti, Nicola Zilio.
Tra tecnica Modema e Progetto
Studio antropologico del design
di Claudio Rocca
editore: Pisa University Press
pagine: 146
Partendo dall’emblematico naufragio di Robinson Crouse per arrivare all’analisi sociologica sull’influenza che il sistema degli oggetti d’uso quotidiano ha sul modo di essere dell’uomo, questo studio prende in considerazione il “bricolage” in quanto dispositivo che parla della nostra relazione identitaria con gli oggetti. Si svela così il moltiplicarsi delle catene “fai da te” e la risposta della società digitale che si sta evolvendo verso nuove forme di autoproduzione, di comunità informatiche, nuove tecnologie (stampanti 3D e FabLab) e nuovi materiali. La ricerca affronta così il modello antropologico che studia la moda e la teoria dei modemi, attraverso i quali si interpreta con una diversa e più ampia visione il mondo del design e la sua indessicalizzazione.La Vespa della Piaggio è il “case study” scelto dall’autore per approfondire una ricerca diacronica sugli scooter italiani del dopoguerra, la nascita e la tecnica del progetto, insieme alla teoria dei modemi e allo styling
Il melodramma cinematografico
Campioni di fantasia tragica
di Stefano Socci
editore: Pisa University Press
pagine: 160
Questo libro è un itinerario attraverso il melodramma cinematografico, che si nutre di emozioni e sentimenti, cioè di vicende essenzialmente intime e private, ma è capace di assorbire il senso e lo spirito dei tempi, di mutamenti antropologici, economici, politici e sociali. Il melodramma viene da lontano, i suoi elementi si sono codificati e precisati molto prima della comparsa della settima arte. Grazie a queste fitte e profonde radici, espressive, mitologiche, stilistiche e teoriche, è una delle migliori chiavi di lettura – e un eccellente veicolo di conoscenza – della storia del cinema, anche in rapporto alle metamorfosi della rappresentazione. Nell’introduzione viene descritto il percorso del melodramma, dal Cinquecento ai nostri giorni, dal palcoscenico al grande schermo. Nel primo capitolo è illustrato, in ordine cronologico, lo sviluppo del melodramma nel inema, elencando e analizzando molti titoli significativi, dal periodo muto alla contemporaneità. Il secondo capitolo si concentra su dodici film importanti, dal 1939 al 2015: Via col vento di Fleming, Pandora di Lewin, Casco d’oro di Becker, Senso di Visconti, Secondo amore di Sirk, Le lacrime amare di Petra von Kant di Fassbinder, L’ultimo imperatore di Bertolucci, Le onde del destino di von Trier, In the Mood for Love di Kar-wai, I segreti di Brokeback Mountain di Lee, La migliore offerta di Tornatore, Carol di Haynes.
II cannocchiale
di Jean-Charles-Leonard Sismonde de Sismondi
editore: Pisa University Press
pagine: 160
Durante il suo soggiorno londinese nella primavera 1793, la famiglia Simonde visitò, tra le molte altre attrazioni turistiche, anche il telescopio di William Herschel, situato a circa 40 miglia lontano da Londra, noto come Observatory House. La possibilità di guardare alla volta celeste con questo mastodontico strumento – lungo 12 metri e con alla base un specchio concavo di 120 cm di diametro – deve aver suscitato una forte impressione sul giovane Sismondi, all’epoca ventenne.Ci piace pensare che sia nata da quest’esperienza l’idea di intitolare il suo giornale satirico con il nome di Cannocchiale. Contrariamente a molti altri scritti, contemporanei e successivi, il testo infatti abbonda di metafore attinte all’astronomia: si legga ad esempio quando Sismondi, novello Gulliver, approda nell’isola della Superbia e tramite il cannocchiale della modestia riesce a rendersi conto che gli abitanti dell’isola, invece di essere una turba di gente rissosa, sono in realtà dei piccoli geni lillipuziani; o ancora quando definisce i baldi giovani che corteggiano le donne sposate «i satelliti minori delle belle», distanziandoli però nella loro superficialità, da quelle «comete erranti che secondo il sistema dell’Universo del Prof. Lambert, vanno da un sistema planetario a un altro, descrivendo lunghissime elipsi, ma avendo intorno a ciaschedun astro un perielio molto corto».
Come scrive però Alessio Bini, nel saggio che precede il testo, le ragioni sostanziali per cui Sismondi attinge a questa metafora sono ben altre. Ricordando come il cannocchiale galileiano abbia messo a tacere la cosmologia e il sensismo aristotelici, Bini suggerisce di considerare la funzione specifica svolta dal cannocchiale, che è quella «di aiutare la ragione a capire com’è fatto il mondo, potenziando i sensi». Vi è dunque anche una non celata motivazione pedagogica innata in questa impresa letteraria, che è quella di educare una società (nello specifico, quella pesciatina) a guardare a se stessa con ironia, a mettere in discussione quanto è dato per acquisito, confrontandosi con altri mondi e altri costumi
Nuove Musiche 1/2016
rivista: Nuove Musiche
pagine: 164
La rivista «Nuove Musiche» nasce dal sodalizio tra il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Palermo e la Fondazione Prometeo di Parma. Essa colma una lacuna dell'attuale panorama editoriale italiano, privo di un periodico di alto profilo accademico monograficamente dedito alla musica contemporanea. Dotata di un comitato scientifico internazionale e applicando procedure di peer review, la rivista esce, in edizione multilingue, in versione sia digitale sia cartacea. Suo oggetto di studio è l'intero campo mondiale della musica d'oggi, con una prospettiva privilegiata sulla situazione italiana.
Lo sguardo di «Nuove Musiche» mira alla convergenza metodologica dei vari approcci della musicologia: storico, estetico, analitico, teorico-sistematico, socio-antropologico, psico-neurologico, semiotico, mediale, economico. Cioè alla convergenza tra la musicologia stessa e le altre discipline della conoscenza, nell'ideale di un umanesimo aggiornato. Oggi in Italia il dibattito sulla musica contemporanea si svolge perlopiù in un ambito ristretto e separato, «Nuove Musiche» invece punta a integrare la riflessione sulla musica contemporanea nella vita culturale nel senso più vasto. Perciò la rivista ospita studi scientifici ma anche contributi liberi di compositori, interpreti e organizzatori, e si rivolge al pubblico della musicologia accademica internazionale ma anche agli “addetti ai lavori” della musica contemporanea e a tutte le persone interessate.
The scientific journal «Nuove Musiche» is the result of a partnership between the Department of Humanities of the University of Palermo and the Prometeo Foundation of Parma. It fills a gap in the present Italian publishing scene, devoid of a high academic profile periodical monographically dedicated to contemporary music. Provided with an international scientific committee, and using peer review procedures, the journal will be released, in multilingual edition, in both digital and printed version. Its object of study is the worldwide field of contemporary music, with a privileged look at the Italian situation.The perspective of «Nuove Musiche» aims at the methodological convergence of the various approaches of musicology: historical, analytical, aesthetic, systematic, semiotic, anthropological, sociological, psycho- and neurological, media-theoretical, economic. That is, at the convergence between musicology itself and the other branches of knowledge, according to an updated ideal of the humanities. Today in Italy the debate on contemporary music takes place mostly in a narrow and separate field. Instead, «Nuove Musiche» aims at integrating the reflection about contemporary music into the cultural life in the broadest sense. Therefore, the journal features scientific studies as well as free contributions by composers, performers, organizers, and addresses the scholarly audience, but also all contemporary music operators anDd all interested people.
In questo numero:
Editoriale – EditorialMartino Traversa, Stefano Lombardi Vallauri - Editoriale – EditorialTradizioni
Paolo Emilio Carapezza, Gian Paolo Minardi - Tradizioni
Vectoriality/Protension in Post-Tonal Musicedited by Stefano Lombardi Vallauri
Stefano Lombardi Vallauri - Introduction
Giovanni Guanti - A friendly reminder: get used to the unheard not to end up devoured Elisa Negretto - Analysis of the temporal structures underlying the listeners’ experience of tension
Alessandro Cecchi - Formal tension in Energetics and beyond
Alberto E. Colla - The theory of harmonic tension and resolution during the 20th century
Nathalie Hérold - Timbral vectoriality: some considerations in the context of post-tonal music
Giacomo Albert - Vectoriality and protension vs symmetries and endless processes in minimalist music: some reflections stemming from the analysis
of the sketches of Steve Reich’s It’s Gonna RainIngrid Pustijanac - Time’s arrow in spectral music
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE. SCULTURA 1784-1915
di Sandro Bellesi
editore: Pisa University Press
pagine: 416
Il libro, frutto di anni di ricerche condotte prevalentemente su fonti archivistiche e letterarie da studiosi di primo piano, nasce dall’esigenza di “ricostruire” la storia dell’Accademia di Belle Arti di Firenze e di mettere finalmente in luce il suo prestigioso patrimonio artistico, oggi “ospitato”, in gran parte, in vari musei cittadini. Primo di una serie di studi rivolti alle scuole artistiche dell’Accademia, il volume, dedicato alla Scultura e ai suoi protagonisti dal momento della fondazione fino all’inizio del Novecento, focalizza l’importanza rivestita da questo istituto educativo, sempre al centro della vita artistica fiorentina, al quale spettò, tra l’altro, la salvaguardia e la tutela del patrimonio pittorico-scultoreo toscano, come testimonia, ad esempio, l’intervento risolutivo del presidente Giovanni Degli Alessandri, che nel 1808, in seguito alle leggi emanate dal governo napoleonico, salvò dalla dispersione gran parte delle opere quattro-cinquetentesche provenienti dai conventi soppressi, facendo sì che queste fossero concesse “all’Accademia delle Belle Arti in onorevol memoria dei Figli Suoi e per Istruzione dei Nuovi dell’Accademia medesima”. Insieme alle indagini dedicate ai professori di Scultura che nel corso del tempo hanno guidato la scuola, primo fra tutti il geniale Lorenzo Bartolini, il volume, che analizza per la prima volta in modo dettagliato l’evoluzione delle arti plastiche nel capoluogo toscano tra la fine del Settecento e l’Ottocento, focalizza l’attenzione sui princìpi di insegnamento attuati dai singoli maestri e sulle raccolte artistiche, incentrate, prevalentemente, su statue e bassorilievi in gesso eseguiti dalle giovani leve in occasione di concorsi o inviati dalle stesse nel corso dei cosiddetti “pensionati” a Roma. Proprio grazie a queste nuove indagini è stato così possibile identificare gli autori dei bassorilievi originali ottocenteschi, vanto delle raccolte artistiche attuali dell’Accademia, finora in gran parte anonimi e inediti. Il libro, per esigenze di indagine, si è prefisso come termine cronologico il 1915, anno d’inizio della prima guerra mondiale e tempo di cambiamenti radicali all’interno della Scuola. Per supplire alla mancanza di uno studio “contemporaneo” sulle arti plastiche è previsto, dopo un volume analogo al presente dedicato alla Pittura, un libro sulle arti del Novecento, dove saranno effettuate ricerche su tutte le scuole artistiche presenti all’Accademia di Belle Arti di Firenze.
Il libro curato da Sandro Bellesi, introdotto da cinque presentazioni (Luciano Modica, Eugenio Cecioni, Cristina Acidini, Luigi Zangheri e il curatore), raccoglie diciotto saggi. Questi, distribuiti in sezioni differenziate, portano la firma di Michele Amedei, Sandro Bellesi, Silvestra Bietoletti, Valeria Bruni, Rossella Campana, Annarita Caputo, Giovanna Cassese, Giulia Coco, Cristina Frulli, Francesca Lotti, Daniele Mazzolai, Fabrizio Paolucci, Francesca Petrucci, Roberta Roani, Enrico Sartoni, Giandomenico Semeraro ed Ettore Spalletti. Le schede delle opere presenti volume sono state redatte da alcuni autori dei saggi e da Caterina Del Vivo ed Elena Marconi.
Il profilo stilistico del testo
Guida al confronto intertestuale e interculturale (tedesco e italiano)
di Marina Foschi
editore: Pisa University Press
pagine: 232
Il volume presenta un approcio descrittivo allo stile del testo, letterario e non letterario. La base teorica proviene da una visione a largo raggio sugli studi stilistici che, partendo dalla retorica antica, arriva a considerare con particolare attenzione gli sviluppi più recenti di scuola tedesca: la stilistica testuale (Textstilistik) e la testologia contrastiva (kontrastive Textologie). Ne deriva un'accezione di stile come fenomeno sociale e culturale, il cui profilo è rilevabile nelle strutture formali e pragmatiche del testo grazie a un confronto intertestuale mediato da istanze adeguate. Le tecniche e categorie presentate riassumono i maggiori risultati della linguistica testuale di scuola tedesca, senza tralasciare lo strumentario retorico tradizionale. Pur rivolgendosi in particolare a un pubblico di studenti e studiosi di germanistica e DaF, l'analisi stilistica presentata nel volume può adattarsi a ogni lingua e cultura, gli esempi prodotti facilmente sostituibili con testi equivalenti in italiano o altre lingue.
Medioevo volgare germanico
nuova edizione
di Marco Battaglia
editore: Pisa University Press
pagine: 252
La nascita di uno statuto letterario germanico, durante l’Alto Medioevo, rappresentò una conquista culturale mediata dalla cristianizzazione e dalle relative necessità liturgiche, dottrinarie ed esegetiche. Poiché la conversione al Cristianesimo delle numerose etnie germaniche richiese quasi un millennio, non stupisce che il diverso grado di integrazione delle élite barbariche nell’universo dottrinario e culturale della Chiesa – erede di molti valori della cultura greco-romana – si tradusse in una altrettanto lenta percezione della dignità dei propri volgari in funzione di lingua scritta, la cui forma richiedeva l’acquisizione di una coscienza ‘alfabetica’ e di forme ‘scrittorie’ locali ancora inedite. La frammentazione culturale che ne conseguì e la prolungata assenza di un canone alfabetico univoco per le singole lingue – unitamente all’egemonia esercitata ancora per secoli dalla cultura latina – si tradusse in risultati letterari tra loro disomogenei in ciascuna area linguistica. Il monopolio degli studi e della cultura scritta, esercitato per secoli in Occidente dall’autorità ecclesiastica, ebbe conseguenze dirette sul piano del contenuto e della relativa trasmissione. All’interno dei codici manoscritti realizzati per lo più tra le mura di scriptoria monastici riuscì a filtrare soltanto una minima parte, opportunamente emendata, del patrimonio tradizionale delle culture volgari, patrimonio che continuò viceversa a essere tramandato attraverso i canali impalpabili dell’oralità. Le prime forme di una tradizione letteraria germanica restarono dunque confinate per lungo tempo ad ambiti istituzionali – giuridici, notarili e religiosi –, nei quali i volgari riuscirono inizialmente a far breccia sotto forma di strumenti interpretativi d’immediata utilità, come le glosse esplicative di concetti e di lessemi non immediatamente comprensibili. Medioevo volgare germanico cerca di raccogliere e introdurre i principali documenti e i relativi generi letterari delle singole tradizioni linguistiche del Medioevo germanico, a partire dalla più antica traduzione della Bibbia in gotico fino agli esempi più raffinati del patrimonio letterario poetico e prosastico.
Studi Classici Orientali 2016
vol. LXII
Autori vari
editore: Pisa University Press
pagine: 400
In questo numero:
Giovanni Salmeri, Ricordo di uno storico: Mauro Corsaro
David J. Murphy, ‘By the goose, By the Ram’. Socrates’ other unusual oaths
Luca Asmonti, A note on the meaning of καταλέλυκε in [Ps. Xen.] Ath. Resp. 1.13
Andrew G. Nichols, The Iranian Concept Aša and Greek Views of the Persians
Giorgio Camassa, Salute e salvezza alla fine dei tempi
Federico Russo, Aurum atque ambitio: Fenomeni di ambitus a Roma in età mediorepubblicana
Francesco Verde, Setia, Sacriportus e la marcia di Silla verso Roma
Aurora Maccari, Habebat ius proferendi pomerii (Gell., Noctes Atticae, XIII, 14). L’evoluzione dello ius prolationis dalle origini a Silla
Andrea Samueli, Lo scutum dall’epoca repubblicana a Traiano. Studio e ricostruzione sperimentale di uno scutum legionario
Antonio Campus, Il complesso delle Terme ‘di Nerone’ a Pisa
Sergio Audano, Palinodia consolatoria. A proposito di τὸ κράτιστον in Plut. Cons. ad Apoll. (108E)
Cesare Letta, Fonti scritte non letterarie nella Storia Romana di Cassio Dione
Andrea Beghini, Arcesilao e Numenio: note a fr. 25 des Places (= Eus. Praep. Ev. XIV, 5, 12-13 des Places)
Carlo Ferrari, Tra le steppe e le Gallie: la descrizione degli Unni di Sidonio Apollinare (carm. II, Panegirico di Antemio, 243-269)
Margherita Farina, Barhebraeus’ Metrical Grammar and Ms. BML Or. 298: Codicological and Linguistic Remarks
Maria Assunta Vinchesi, Un letterato patrono di letterati. Riflessioni in margine a una recente edizione dei frammenti di Mecenate e delle testimonianze latine sul personaggio storico
Vestire le statue
Arte, devozione e committenza nella Toscana Nord-occidentale
editore: Pisa University Press
pagine: 218
Frutto della convergenza di studiosi di diverse generazioni, il volume affronta l’affascinante tema delle “statue vestite”, una categoria di immagini sacre ancora largamente trascurate dagli studi storico-artistici. L’ambito territoriale della ricerca è quello della Toscana nord-occidentale, ma in questo universo apparentemente circoscritto tra i monti, il mare e la piana dell’Arno si riflettono aspetti e problemi largamente diffusi nella pratica religiosa dell’intera ecumene cristiana. Dà conto di ciò la struttura stessa del volume, che ad una prima parte di saggi affianca una seconda parte di catalogo. Mentre qui lo sguardo si concentra su trentatré opere analizzate in dettaglio, lì sei punti di vista diversi suggeriscono altrettante proposte di sintesi dei molti dati raccolti. È allegato al libro un documentario nel quale la complessa realtà delle statue vestite s’esprime col linguaggio delle immagini in movimento e del connesso sonoro, offrendo un ulteriore stimolo alla conoscenza ed all’apprezzamento di quei particolarissimi manufatti.
Prima di tradurre
Note sui vincoli strutturali, concettuali e culturali nella traduzione dall’inglese in italiano
di Marcella Bertuccelli Papi
editore: Pisa University Press
pagine: 248
Queste Note non insegnano a tradurre bensì propongono alcune osservazioni come spunti per una riflessione sui vincoli strutturali, concettuali e culturali nella traduzione dall’inglese all’italiano. Si può tradurre in tanti modi, per scopi diversi e con risultati di diversa qualità. Una buona traduzione è spesso il frutto di un talento innato, di un istinto ma, come in tutti i campi del sapere, la riflessione, la ponderazione delle scelte, la consapevolezza della materia con la quale si opera e dei meccanismi del suo funzionamento sono indispensabili per raggiungere risultati stabili e duraturi. Sebbene la traduzione sia una forma raffinata di comunicazione e mediazione interculturale che richiede sensibilità ad una pluralità di aspetti linguistici ed extralinguistici, la prospettiva qui adottata è prevalentemente linguistica: la traduzione è vista cioè dalla prospettiva di due sistemi linguistici comparabili ma anche divergenti in alcune aree della loro organizzazione. Tali divergenze rappresentano vincoli con i quali lo studente dovrà fare costantemente i conti nella pratica traduttiva: acquisirne consapevolezza può essere d’aiuto nel processo di formazione del giovane traduttore.
Egitto e Vicino Oriente 2015
vol.XXXVIII
Autori vari
editore: Pisa University Press
pagine: 204
In questo numero:
Angela Garrè - Per una nuova interpretazione del controverso nome “Misphragmuthosis”
Emanuele Casini - The three-dimensional representations of the human-headed bA-bird: some remarks about their origin and function
Paolo Marini - Uno studio iconografico del rilievo Firenze 5412: una cappella per il culto della dea Renenutet?
Lisa Sartini - The black coffins with yellow decoration: a typological and chronological study
Flora Silvano - Una nuova tipologia vitrea ad Antinoe, Egitto
Fabio Betti, Andrea Gariboldi - Fortuna cristiana di Iupiter in un sigillo dall’Iran Sasanide
Michele Degli Esposti, Walid al-Muzini - A new seal from the ancient oasis of Salut (Central Oman)
Daniele Mascitelli - Le gesta di Šammar Yuriš dall’epigrafia alla tradizione arabo-islamica Un esempio di “costruzione” narrativa della storia preislamica
Marilina Betrò - Il sarcofago e il cartonnage di Tentamonnesuttaui, Firenze n. inv. 2176 e 2173
L'"ebreo" nella letteratura inglese medievale
di Enrico Giaccherini
editore: Pisa University Press
pagine: 208
Chimere”, fantasie irrazionali disancorate dalla realtà verificabile, è il termine con il quale agli inizi degli anni ’90 lo storico canadese Gavin Langmuir definì le rappresentazioni degli ebrei cristallizzate nell’immaginario comune dell’Europa medievale e cristiana. Ecco perché anche quella elaborata in una manciata di testi della narrativa e della drammaturgia medioinglesi soprattutto fra XIV e XV secolo non è una rappresentazione letteraria degli, o di, ebrei nell’Inghilterra del tempo, ma dell’“Ebreo”: una chimera, appunto, una creatura fantastica appartenente allo spazio del mito piuttosto che a quello del reale.Privilegiando, pur senza rinunciare alla indispensabile contestualizzazione “culturale”, l’analisi testuale e letteraria, questa indagine si rivolge in particolare a quelle opere che, sempre nell’ottica del cristianesimo imperante, collocano l’“Ebreo”, nelle sue varie declinazioni, al centro dell’invenzione tematica, con esiti talora sorprendenti. Dopo aver passato in rassegna le sporadiche allusioni presenti nel macrotesto del maggiore autore del medioevo inglese, Geoffrey Chaucer, lo studio affronta quindi in modo specifico i rari testi esemplari di questa tradizione. Se il più celebre di questi è, dello stesso Chaucer, il Prioress’s Tale, o “Racconto della Priora”, dai Canterbury Tales, gli altri appartengono invece al genere del romance storico e a quello teatrale dei miracle plays; in quest’ultimo caso, in particolare, il testo inglese viene messo a confronto con coeve rappresentazioni italiane e francesi che inscenano il medesimo mito della profanazione giudaica dell’ostia consacrata.
L'odium regni a Roma tra realtà politica e finzione storiografica
di Federico Russo
editore: Pisa University Press
pagine: 384
In questo volume sono presentati i risultati di una ricerca svolta all’università di Costanza (Germania) grazie ad un finanziamento della Gerda Henkel Stiftung.
In contrasto con una visione antica e moderna, secondo cui l’odium regni, e cioè l’avversione tipicamente romana per qualunque forma di potere monocratico (ed in particolare quello prettamente monarchico), questa monografia dimostra l’ambiguità dell’atteggiamento romano vero il concetto di regnum. Distinguendosi dalla convinzione tradizionale secondo cui l’odium regni a Roma sarebbe stato una diretta conseguenza dell’esperienza traumatica del regno tirannico di Tarquinio il Superbo, l’indagine mostra, tramite un’analisi di testi di fine III e II secolo a. C., come la riflessione sull’istituto monarchico compaia compiutamente nelle fonti (teatrali e non) di fine III secolo (capitolo 1: “Re e tiranni sulle scene romane”), e si affermi nella coeva e di poco successiva storiografia latina greca solo in conseguenza del contemporaneo dibattito politico interno a Roma. L’emergere di figure per qualche motivo dotate di poteri “straordinari”, cioè non ricadenti entro le normali strutture giuridiche dello stato repubblicano, come il Temporeggiatore e l’Africano, o ancora il ricorso eccessivo, ancorché giustificato dall’emergenza annibalica, alla carica di dittatore, introdussero nel discorso politico l’accusa di adfectatio regni, cioè di aspirazione tirannica, intesa come minaccia al funzionamento delle istituzioni repubblicane. L’accusa di aspirazione monarchica / tirannica si saldò ben presto a quella di demagogia, cosicché quest’ultima fu vista come uno strumento tramite cui lo stato repubblicano poteva essere sovvertito in una monarchia (capitolo 2: “IL concetto di regnum al tempo della seconda guerra punica”; capitolo 4: “Il regnum di P. Cornelio Scipio Africano”). Tracce frammentarie ma esplicite di tale accezione dei concetti di demagogia e monarchia / tirannide emergono non solo nel dibattito politico di Roma mediorepubblicana, ma anche nella riflessione polibiana sull’anakyklosis applicata proprio all’interpretazione che lo storico megapolitano dà dell’ascesa del dominio di Roma (capitolo 6 “Roma come una monarchia? Il tema della translatio imperii”), ed infine nella coeva riconsiderazione storiografica di alcuni episodi del passato di Roma, sia monarchico che repubblicano (capitolo 3: “Connotazioni ideologico-politiche del concetto di regnum”; capitolo 7; “Amulio, Romulo e Tito Tazio: problemi storiografici”). L’indagine mostra dunque come la dialettica tra quattro temi principali, monarchia, la sua quasi inevitabile corruzione in tirannide, demagogia e istituzioni repubblicane ritornino costantemente nella risistemazione storiografica, proprio dell’annalistica di età medio e tardorepubblicana, di alcuni eventi salienti della storia di Roma, rivelando nel contempo l’applicazione di cliché storiografico-interpretativi la cui codificazione si può far risalire al periodo tra la fine del III secolo e l’inizio del II secolo a. C., quando cioè il concetto di regnum irruppe nel discorso politico romano.
Fu quindi in questo lasso di tempo che il concetto di regnum assunse una connotazione negativa, a scapito di accezioni neutre o addirittura positive che ne caratterizzavano l’uso teatrale degli ultimi decenni del III secolo a. C. E tuttavia, un’ulteriore prova di come tale concetto conservasse una posizione ambigua nell’immaginario ideologico romano è fornita dal fatto che nella politica estera di età mediorepubblicana i Romani non si presentarono mai come acerrimi nemici delle monarchie, ma anzi intrattennero con re, ed in particolare con i regni ellenistici, ottimi rapporti diplomatici e politici (capitolo 5: “Omnium regum hostes”). Sarà solo una certa parte della storiografia, coeva (si pensi a Catone) ma più spesso di età tardorepubblicana, che amerà presentare i Romani come l’antitesi par excellence di ogni forma monarchica.
Il volume, dunque, coniugando l’analisi dell’evidenza storiografica con una riflessione sul dibattito politico romano di età mediorepubblicana (capitolo 8: “L’esempio degli adfectores regni. Interferenze tra discorso politico e tradizione storiografica”), mostra l’ambiguità del concetto di regnum nella mentalità romana, determinata in ultima analisi da specifici aspetti delle istituzioni repubblicane romane tra l’età annibalica e il periodo delle guerre d’oltremare.